La Lanterna di Genova è uno dei simboli del capoluogo ligure ed è anche un faro perfettamente funzionante con una lunga storia di assedi, re prigionieri e progressi tecnologici. Situata a poca distanza dal centro città, nell’area di Sanpierdarena, racconta lo sviluppo marittimo del capoluogo ligure dai tempi di Cristoforo Colombo e, insieme ai Palazzi dei Palazzi dei Rolli di Genova, rappresenta una delle testimonianze più affascinanti della grandezza storica della Superba.
Indice dei contenuti
Le origini della Lanterna di Genova
Il faro della Lanterna è una torre storica che, così come la conosciamo ora, esiste dal Cinquecento. Tuttavia la base originale è ancora più antica, come è emerso da ricerche storiche. Già nel 1128, sulla stessa area, sorgeva una torre da cui si controllava l’arrivo di imbarcazioni sospette e si segnalava l’ingresso del porto.
Il complesso monumentale della Lanterna è oggi visitabile, tranne la parte del faro utilizzata dalla Marina Militare per la navigazione. Per maggiori informazioni su biglietti, orari e il percorso di visita, leggi la guida completa alla Lanterna di Genova. Di seguito puoi scoprire le curiosità storiche e architettoniche di questo antico monumento.
Un faro alimentato a olio d’oliva: le prime tecniche di illuminazione
La prima versione del faro di Genova non aveva una vera lampada: si trattava di un semplice braciere posto su una terrazza, dove venivano bruciate fascine per illuminare il porto e segnalare alle imbarcazioni l’ingresso sicuro. Solo nel 1326 fu installata la prima lanterna vera e propria, alimentata con olio d’oliva, che rese la luce più stabile e duratura.
Già allora, prima dell’invenzione della lente di Fresnel, la luce della lampada a olio veniva concentrata in un fascio luminoso grazie a cristalli trasparenti lavorati dai maestri vetrai liguri e veneziani, un ingegnoso sistema ottico che, pur con risultati limitati, rappresentava un grande progresso tecnico per l’epoca.
Quando la Lanterna divenne una prigione
Nel Quattrocento i genovesi trasformarono la torre della Lanterna in una prigione per il re di Cipro Giacomo di Lusignano, sua moglie Eloisa e l’intera corte, che rimasero in ostaggio per diversi anni, secondo le fonti storiche tra cinque e dieci. I documenti dell’epoca non sono del tutto concordi, ma sembra certo che durante la prigionia nacque il loro figlio Giano, evento che aggiunge un capitolo umano e sorprendente alla lunga storia della Lanterna di Genova.
Gli assedi francesi del Cinquecento e i danni alla Lanterna
Tra le sue vicissitudini storiche, Genova visse un periodo di dominazione francese nel Cinquecento, durante il quale il re Luigi XII fece costruire una lunga fortificazione intorno alla città per isolarla dalle montagne e difenderla dal mare, oltre al Forte Briglia, situato ai piedi della Lanterna. Questa struttura militare serviva inizialmente per ospitare le truppe francesi, ma pochi anni dopo venne utilizzata come base per assediare la città stessa.
I genovesi riuscirono comunque a liberarsi dall’invasione grazie alla guida di Andrea Doria, simbolo dell’indipendenza della Repubblica. Tuttavia, durante la battaglia del 1513, nel fuoco del combattimento, venne abbattuta una parte della Lanterna insieme al Forte Briglia, obiettivo principale dell’attacco.
La ricostruzione e la rinascita della Lanterna di Genova
Il faro venne ricostruito nel suo aspetto attuale circa trent’anni dopo, sostituendo le antiche merlature di gusto medievale con una più elegante decorazione rinascimentale. Per questo motivo gli studiosi dibattono ancora oggi se datare la Lanterna al 1128, anno delle prime fonti documentate, oppure mantenere la datazione convenzionale del 1543, legata alla seconda ricostruzione.
La nuova Lanterna fu realizzata in doghe di legno di rovere, ricoperte da fogli di rame e piombo fissati con circa seicento chiodi di rame, un dettaglio che le cronache dell’epoca riportano con orgoglio insieme ad altri particolari architettonici. All’epoca della ricostruzione la torre presentava un’ampia vetrata lavorata da maestri vetrai liguri e veneziani, con vetri spessi e pesanti che si spaccavano o esplodevano spesso a causa del vento o dei fulmini.
Il compito dei fanalisti, i custodi che vivevano alla Lanterna con le loro famiglie, era proprio quello di pulire e mantenere lucidi i vetri, affinché la luce apparisse chiara e brillante ai naviganti. Solo una ventina d’anni più tardi, nel 1565, la cupola subì un intervento per renderla stagna; fu poi rifatta completamente nel 1681 in legno di castagno, isolata con pece e stoppa, e ricoperta da fogli di piombo con i bordi sovrapposti.
Il ritorno dei francesi e i nuovi bombardamenti
I rapporti tra la Repubblica di Genova e la Francia non furono mai davvero pacifici. Nel 1684, durante una nuova offensiva, re Luigi XIV ordinò il bombardamento della città, colpendo anche la Lanterna: una delle cannonate centrò in pieno la grande vetrata del faro. La struttura venne ricostruita provvisoriamente, ma solo nel 1692 fu modificata in modo più stabile, con nuovi vetri rinforzati per resistere meglio alle cannonate e alle intemperie che minacciavano costantemente il simbolo della Superba.
I restauri e i rinforzi strutturali nel corso dei secoli
Da quel momento, la Lanterna di Genova riuscì a sopravvivere indenne a numerosi eventi storici, dalle battaglie del 1746 dopo la rivolta di Portoria fino ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Tuttavia, a minacciare realmente la sua stabilità non furono tanto gli assedi o le cannonate francesi, quanto i fulmini, che colpivano frequentemente la torre causando gravi danni.
Nel 1771 la Lanterna fu rinforzata con chiavarde e tiranti in ferro, visibili ancora oggi lungo le scale interne durante la visita. Questa innovazione rese la struttura più solida ma al tempo stesso flessibile, capace di resistere alle vibrazioni e alle raffiche di vento. Qualche anno più tardi, nel 1778, venne installato anche un parafulmine, una delle prime applicazioni di questo dispositivo in Italia, per proteggere il faro dai violenti temporali che si abbattevano sul promontorio.
La Lanterna di Genova come faro moderno di navigazione
L’arrivo delle innovazioni ottiche e dei nuovi combustibili segnò per la Lanterna di Genova un vero e proprio salto tecnologico. Nel 1840 venne installata la prima ottica rotante, una lampada capace di ruotare su se stessa grazie a un ingegnoso meccanismo che permetteva alla luce di essere visibile a intervalli regolari. Al suo interno fu montata una lente di Fresnel, una delle più moderne dell’epoca, progettata per raccogliere e diffondere in modo uniforme la luce.
La nuova sorgente luminosa aveva un diametro di circa quattro metri e la sua luce poteva essere vista fino a venti miglia nautiche di distanza, equivalenti a quasi quaranta chilometri. Questo importante aggiornamento tecnico salvò la Lanterna dal rischio di essere declassata e le permise di continuare a svolgere un ruolo fondamentale come faro di navigazione nel Mediterraneo.
Innovazioni tecnologiche e manutenzione del faro
Dalla fine dell’Ottocento la Lanterna di Genova attraversò una fase di rapida evoluzione tecnologica. Il faro passò dapprima al gas di acetilene come combustibile, poi al petrolio pressurizzato, fino ad arrivare alla completa elettrificazione nel 1936, che rese la gestione della luce più stabile e sicura.
La lampada principale venne sostituita nel 1956, poiché danneggiata dai bombardamenti dell’aviazione statunitense e britannica durante la Seconda guerra mondiale. In quell’occasione si procedette anche al rinnovamento totale dell’ottica rotante e dei suoi complessi meccanismi di movimento.
Durante la stessa ristrutturazione fu ritinteggiato lo stemma della Repubblica Marinara che oggi spicca sulla torre, simbolo inconfondibile della Superba. Vennero inoltre installati un impianto elettrico di emergenza e un ascensore riservato alla Marina Militare, rendendo la Lanterna un faro moderno, efficiente e ancora pienamente operativo.

Curiosità e leggende sulla Lanterna di Genova
La Lanterna di Genova è avvolta da un’aura di mistero e fascino, alimentata da leggende popolari e aneddoti storici tramandati nei secoli. Una delle storie più note racconta che il primo progettista del faro sarebbe stato gettato giù dalla sommità della torre per impedire che costruisse un’altra lanterna simile altrove. Un’altra versione, più ironica, attribuisce il gesto alla presunta parsimonia dei genovesi, che in questo modo avrebbero evitato di pagargli il compenso a fine lavori.
Durante la visita alla torre, salendo lungo le scale interne, si possono notare ganci e catene in ferro risalenti al 1771, aggiunti per rendere la struttura più flessibile nonostante fosse costruita in pietra. Questo accorgimento architettonico anticipò di secoli il principio costruttivo dei moderni grattacieli, solidi ma al tempo stesso elastici.
In passato, sulle pareti della Lanterna venivano dipinte invocazioni ai santi per proteggerla dai fulmini che spesso la colpivano. Tra i suoi custodi più illustri figura anche Antonio Colombo, zio del celebre navigatore Cristoforo Colombo, registrato nei documenti del faro nel 1449.
Se la storia della Lanterna di Genova ti ha affascinato, aggiungila alla tua lista di luoghi da visitare nel capoluogo ligure. Dopo aver scoperto di persona uno dei simboli più amati della Superba, racconta nei commenti la tua visita alla Lanterna o se ti piacerebbe ammirarla dal vivo.
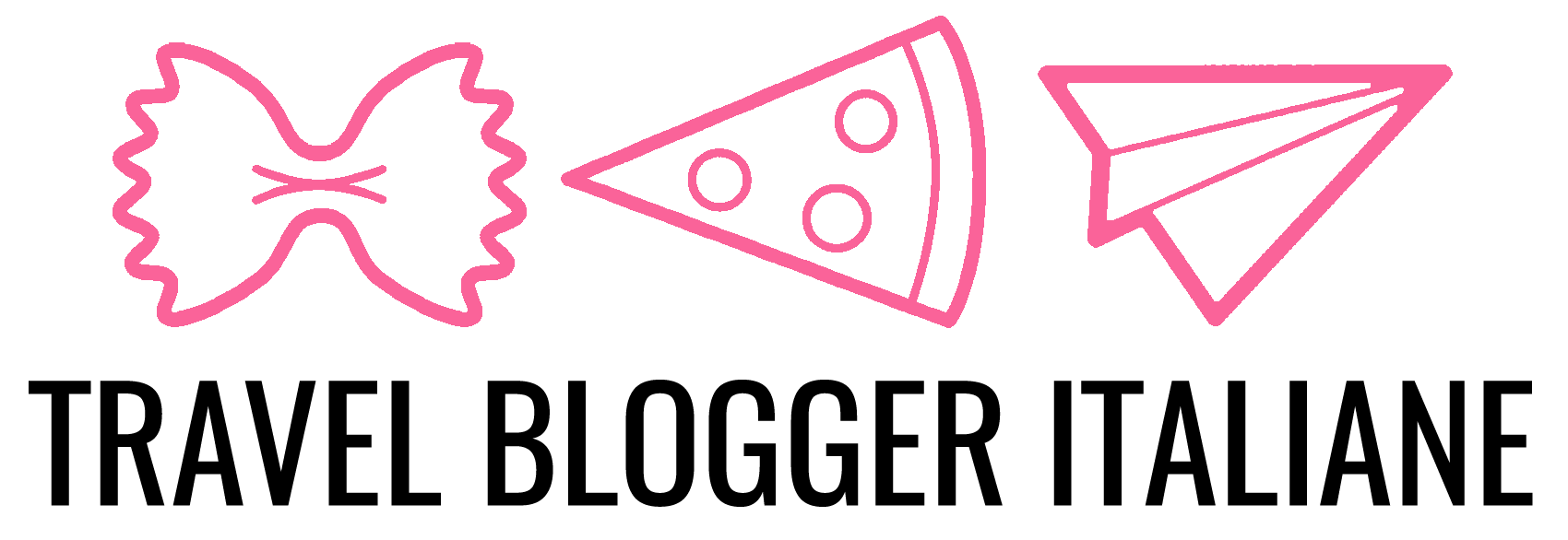

13 commenti
Dall’olio di oliva al gas di acetilene fino alla corrente elettrica! Incredibile anche la storia dei combustibili della Lanterna di Genova! Comunque i progettisti antichi facevano spesso brutte fini!
Non conoscevo la storia della Lanterna. A quanto pare è una vicenda di distruzione e rinascita, come nel caso di molti altri monumenti italiani. Veramente un affascinate viaggio nella storia!… Se non fosse per il povero architetto, la storia dei genovesi tirchi che ricorrono a qualsiasi stratagemma pur di risparmiare sarebbe divertente!
Ahahahah la leggenda dell’architetto è veramente nello stile genovese 🙂
Che piacere leggere della lanterna di Genova. Mia suocera è genovese e quindi conosco molto bene storie e tradizioni locali di questa straordinaria città marinara. ben vengano articoli come questi che focalizzano l’attenzione su un monumento in particolare.
Mi vergogno quasi a dirlo ma non sono ancora stata a Genova. Sicuramente la Lanterna mi piacerebbe visitarla, dato che è il simbolo della città (tra l’altro il costo è decisamente abbordabile, credo valga assolutamente la pena inserirla in un itinerario di viaggio).
Un passato travagliato per il simbolo che tutti i genovesi sentono come loro! Non sapevo del fatto che un tempo andasse ad olio d’oliva, davvero eccezionale come curiosità!
Ho visto Genova in passato ma non ho mai visitato la Lanterna, mea culpa. Leggendo l’articolo mi è venuta voglia di colmare questa mancanza. Interessanti i cenni storici, affascinati le curiosità, soprattutto quelle sul costruttore, che come tanti suoi colleghi si dice siano stati impossibilitati a replicare le loro meraviglie. Anche se in questo caso propendo nel credere che sia stato per non pagare il conto, sono Genovesi!
Non conoscevo la storia della Lanterna di Genova e devo dire che è molto affascinante e sicuramente quando andrò in questa città la inserirò nel mio itinerario. Non posso credere che i genovesi abbiamo addirittura ucciso il costruttore per non pagarlo propendo più per una caduta accidentale.
Ahahah i genovesi qui al nord sono famosi per essere particolarmente tirchi, da cui la leggenda. Tuttavia non conosco genovesi doc quindi non posso confermare!
Sono dei miti questi genovesi, quindi il detto che sono di braccino corto sembra proprio vero, non conoscevo la storia della lanterna, mi è piaciuto leggerla
Ahahah pare proprio di sì, poveri genovesi che brutta fama 🙂
Sono stata a Genova tanti anni fa ormai, forse sarebbe il momento per ritornare. La storia della lanterna non la conoscevo, grazie per tutte queste informazioni
Devi assolutamente tornare, secondo me Genova è una di quelle città che riservano sorprese a ogni visita!